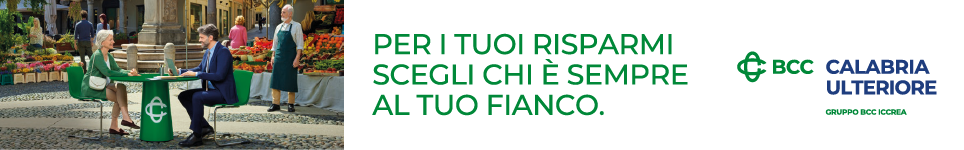di Mimmo Petullà
E’ da auspicare che lo scenario, raffigurante il periodo successivo alle imminenti elezioni europee, possa creare le condizioni per rilanciare una delle sfide più irrisolte del nostro tempo, vale a dire l’affermazione di un Mezzogiorno d’Italia da considerare come una priorità dell’Europa. Ci troviamo di fronte a un’argomentazione estremamente delicata, sebbene mortificata e marginalizzata dal più ampio ordinamento partitico e rappresentativo, tra l’altro a motivo dell’incapacità di raccogliere e rafforzare il pensiero che ha animato la complessità dell’azione meridionalista. In tutto ciò a fare la sua parte è stata anche la presenza intellettuale, la cui funzione – priva di un’intrinseca e solida rete di relazioni – si è rivelata diffusamente avulsa dai linguaggi del collettivo, oltre che non pienamente libera da contraddizioni storiche e contrapposizioni ideologiche. Gli esiti di questo processo si lasciano cogliere nel progressivo deterioramento di un patrimonio storico e culturale, fatto di lotte civili tese a riportare la questione meridionale all’interno di una più generale prospettiva politica.
A ben vedere si tratta di un tema ancora aperto – – anche se non nelle identiche forme e proporzioni del passato – tenendo conto che attende ancora spiegazioni plausibili e parole più incisive dall’Italia di ieri e di oggi. Alla sua discussione non si può più assistere in un paralizzante silenzio, pagandone le spese com’è accaduto a intere generazioni, che hanno subìto l’impatto di una sospensione della politica del meridionalismo, da cui è scaturita una disorientante fluttuazione del sistema di verità e di conoscenza, oltre che una non sottovalutabile crisi di senso. E’ da immaginare che anche per queste motivazioni d’insieme la Calabria continui a essere rigurgitata da Dio e dal mondo, mentre fa sempre più fatica a strascicare il suo crudele destino, che ogni tanto cerca di esorcizzare consegnandolo ai rituali degli interventi provvisori e straordinari, nella vana attesa del balzo occupazionale, puntualmente stroncato dagli impietosi ed esponenziali dati marcanti i confini dell’antico e irriducibile dualismo tra Nord e Sud. Il contesto esposto paga anche lo scotto di comunità ecclesiali la cui prassi pastorale – spesso ripetitiva e chiusa al rinnovamento – non ha saputo e voluto valorizzare pienamente la religiosità popolare, incoraggiando la trasformazione delle sue indubbie potenzialità in un progetto di liberazione sociopolitica.
Nell’ambito del territorio si fanno nel frattempo spazio – in mancanza di altro – nuove realtà politiche, alcune delle quali sembrano puntare su metamorfosi ideologiche e sulla dilagante e disgregante perdita di memoria identitaria delle genti. La ‘ndrangheta dal canto suo continua a spadroneggiare, dal momento che agli incessanti e decisivi interventi della magistratura e delle forze dell’ordine non sembra seguire una diffusa e condivisa reazione di mobilità da parte della società civile. Si ha ciò nonostante maggiore contezza – se non altro rispetto a prima – che quest’odioso fenomeno rappresenti anche una problematica italiana, mentre si registra la nascita di molteplici forme di organizzazione del sociale che tentano in qualunque modo d’incoraggiare una pensabile e più critica assunzione di consapevolezza. Tutto questo, però, sembra tralasciare il fatto – sul quale forse sarebbe opportuno insistere ulteriormente – di trovarsi di fronte a una moltitudine di cittadini la cui sfiducia e senso d’impotenza si rilevano come una caratteristica strutturale e persistente, acuita da un’esistenza affamata e risucchiata nelle strettoie della povertà culturale e nello squallore urbano e infrastrutturale.
Sembra evidente che quanto detto non esime i calabresi di sforzarsi di essere i protagonisti del proprio riscatto, ma questo non dispensa la politica nazionale – come sino a ora è sostanzialmente accaduto – dal dovere di costruire una nuova e più solidale corresponsabilità. Il quadro situazionale attuale impone, appunto per questo, la presenza e la coesione di forze partitiche e istituzionali capaci di recuperare, custodire e restituire le ragioni della memoria storica, rammentando peraltro che il male – per quanto ingiusto e condannabile – non ha mai una sola faccia. In ogni caso nessun impegno può essere credibile e fecondo, se l’obiettivo fondamentale non sarà quello di richiamare una maggiore attenzione dell’Europa sulla Calabria e sulla più ampia area geopolitica del Mediterraneo, fronteggiandone i bisogni e le tensioni che si sono accumulati, ma anche rinvigorendone le antiche radici e valorizzandone le potenzialità.