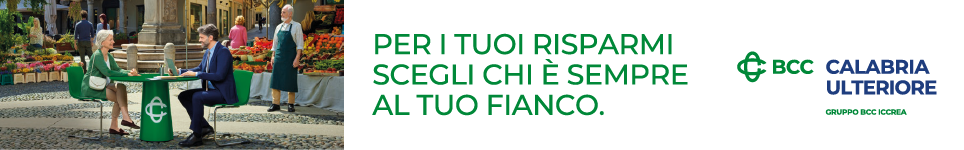Napoleone incrociava le braccia dietro la schiena e Mussolini appoggiava le mani sui fianchi. Carlo d’Inghilterra intreccia le dita e Carolina di Monaco è stata più volte sorpresa mentre è intenta a succhiarsi avidamente un pollice o a toccarsi il naso. Un’esperienza analoga è toccata anche a Claudia Cardinale. Ma per lei, come per Franca Valeri che si toccava costantemente la frangia, il bersaglio sono i capelli.
Raccontati così, questi vezzi, tic e piccole manie potrebbero sembrare appannaggio solo di regnanti, uomini politici, attori e attrici famose. Ma chi di noi se la sentirebbe di giurare di non essersi mai ritrovato ad aggiustarsi nervosamente il nodo della cravatta, o a tormentarsi le dita in una situazione di disagio? Tutti, proprio tutti, anche se non ce ne accorgiamo, siamo autori di gesti ripetitivi, inconsapevoli e incontrollabili.
C’è chi si gratta la testa o si tocca continuamente il naso, c’è chi si liscia i baffi e si accarezza la barba, c’è chi si frega le mani e chi si liscia l’abito, chi accavalla le gambe e chi, in tasca, fa tintinnare chiavi o monete. Ma perché compiamo questi gesti? E che significato possono avere?
Afferma Luigi De Marchi che “Ripetere inconsciamente i medesimi atteggiamenti è un modo per scaricare la tensione o per manifestare i nostri stati emotivi nascosti, come l’ansia, il disagio e così via. Molti atteggiamenti, inoltre, rappresentano difese simboliche del corpo contro paure e minacce che provengono dall’esterno”.
Secondo la bioenergetica, scienza che studia il linguaggio del corpo, è dunque l’energia che governa le nostre emozioni a governare anche i nostri movimenti. Ciò significa che a determinati stati emozionali corrispondono determinati atteggiamenti; in altre parole che anche il corpo ha il suo linguaggio e che le sue parole sono per l’appunto i gesti.
Ora, più che reprimerli, l’importante sarebbe riuscire ad interpretarli per risalire così alle cause che li determinano ed eventualmente eliminarle. Saperli leggere poi in noi e negli altri potrebbe essere veramente utile, potrebbe condurci infatti ad una maggiore reciproca comprensione.
Una volta intrapresa questa via, bisogna però fare attenzione a non incorrere in possibili equivoci. Perché proprio come le parole non sono le stesse perché esistono linguaggi diversi, così anche i segnali del corpo si differenziano secondo le diverse realtà geografiche e culturali. Un esempio, quando un americano vuole segnalare che qualcosa va bene dice ok, solleva una mano e fa un piccolo cerchio con il pollice e l’indice. Lo stesso gesto per un italiano indica qualcosa di diverso: significa non vali niente. Per un giapponese, infine, questo gesto vuol dire denaro oppure affare ben piazzato.
Ogni realtà sociale, insomma sviluppa una gamma infinita di gesti e di segnali visivi.
Ora, stabilire una geografia dei gesti è piuttosto difficile: per capire come si modificano, passando da una località all’altra, occorre collegarli a eventi storici passati.
Prendiamo un esempio che ci riguarda da vicino. Nell’Italia del nord, passare velocemente le dita sotto il mento è un gesto offensivo: va al diavolo. Al sud, invece, pur essendo un messaggio ugualmente negativo, questo gesto non è un insulto: significa semplicemente non posso oppure non ne voglio.
Come è possibile una tale differenza? La spiegazione sta nella storia: i greci colonizzarono l’Italia meridionale arrestando la loro marcia di conquista fra Roma e Napoli. E pare proprio che i mitici soldati dell’antica Grecia si fregassero il mento proprio come gli italiani del sud.
Quanto al nord, le cose dovettero andare in modo diverso.