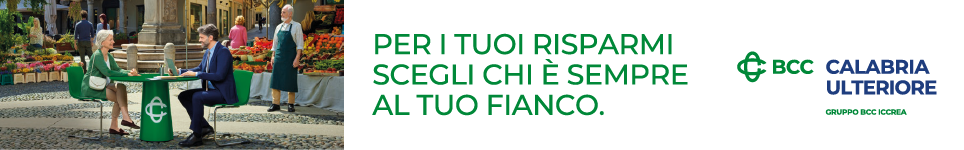Editoriale di Bartolo Ciccardini
Scalfaro e la crisi della partitocrazia
Editoriale di Bartolo Ciccardini
È giusto esprimere un giudizio forte nei confronti dei guasti operati da un partitocrazia degenerata, ma bisogna altresì prendere coscienza di quanto fossero importanti, forti e creativi i partiti nel momento in cui dettero la loro impronta alla “costituzione materiale”, vale a dire alla concreta realizzazione dei valori della Costituzione nel periodo della loro egemonia.
Bisogna ricordare cosa fossero i partiti allora: erano grandi organismi che sapevano mobilitare le masse, che proponevano una cultura fondante della vita stessa del Paese, che esercitavano una capacità di promozione e di emancipazione delle forze popolari da cui traevano quadri ed aristocrazie, ed infine costituivano un vero e proprio assetto sociale con valori e pratiche democratici. Erano nati nella Resistenza e ciascuno di loro aveva saputo mettere in campo un esercito di giovani per combattere lo straniero e riscattare l’Italia. Erano riusciti a mediare le loro divergenze scrivendo una Carta Costituzionale, piena di ideali e di speranze. Erano migliori della società da cui traevano legittimazione.
Se non si capisce questa forza storica dei partiti democratici dopo la parentesi fascista, non si capisce la ragione e la forza della partitocrazia e, subito dopo, il suo decadimento e la sua trasformazione in un potere soffocante che impediva la maturazione democratica del Paese.
Fin dall’inizio di questa esperienza storica la Presidenza della Repubblica è stato un istituto destinato a correggere con i suoi poteri straordinari lo strapotere dei partiti. Secondo la Carta Costituzionale, il Presidente della Repubblica aveva alcuni poteri essenziali (la scelta del Presidente del Consiglio e lo scioglimento delle Camere), che limitavano l’azione dei partiti. E subito i Presidenti della Repubblica diventarono il contrappeso delle scelte, ancorchè legittime, della partitocrazia. È da notare come Einaudi fu eletto Presidente contro il candidato di De Gasperi che pur era l’ottimo Carlo Sforza. Nel periodo in cui Fanfani segretario del Partito era il centro della politica, fu una coalizione antifanfaniana ad eleggere Giovanni Gronchi. E così accadde per Giuseppe Saragat, per Sandro Pertini, per Oscar Luigi Scalfaro.
In controtendenza a questa funzione antipartitocratica furono eletti tre Presidenti. Antonio Segni rappresentò una vittoria dell’orgoglio democratico-cristiano, che riaffermò il suo diritto a scegliere il Presidente della Repubblica. Anche Leone fu la reazione al settennato di Saragat, che aveva un significato più laico e più antipartitico. Ma nel momento della più forte crisi della democrazia fu esemplare la scelta di Pertini che era inviso perfino al suo partito, ma rappresentava un’istanza di forza e di liberazione al di sopra della crisi dei partiti. Anche Cossiga fu eletto da un accordo dei partiti maggiori, addirittura al primo scrutinio. Eppure si manifestò pubblicamente come un Presidente critico del sistema ormai morente dei partiti.
Quando il sistema dei partiti entrò in crisi con il moto referendario e fu messa in discussione la legittimità della aristocrazia partitica nella speranza di una democrazia più diretta si trovò a dirigere la crisi un uomo che era stato sempre in controtendenza alla logica dei partiti. Pur essendo un notabile che aveva partecipato alla Costituente, Scalfaro era stato sempre espressione di piccoli gruppi protestatari e critici sulla gestione politica dei partiti. Fu questa sua natura di “irregolare” che favorì la sua candidatura in un momento di stallo del Parlamento, proposta addirittura da un “irregolare” Pannella. Nella sua Presidenza parve quello che realmente era stato: un indipendente, cattolico, nelle liste della Democrazia Cristiana.
E toccò a lui dirigere la grande crisi della partitocrazia. E questo fu il suo capolavoro politico.
Riuscì a frenare, a torto o a ragione, la rivoluzione referendaria. Riuscì a rispondere con onestà e responsabilità all’assalto dei giudici di “mani pulite”. Usò con indipendenza dei poteri presidenziali per scegliere il Presidente del Consiglio in maniera significativa. Scelse Amato e non Craxi, mentre turbinava l’assalto dei giudici. Scelse Ciampi e non Segni, utilizzando la grande autorevolezza della Banca d’Italia per dare una soluzione alla crisi economica. Scelse la continuità della legislatura nella prima crisi di Berlusconi, chiamando a Presidente del Consiglio Lamberto Dini, con una diversa maggioranza, rifiutando di sciogliere il Parlamento. E portò a termine il suo settennato riconfermando che il Parlamento non poteva essere sottomesso ad una maggioranza virtuale e plebiscitaria del Presidente del Consiglio.
Scalfaro ha sbarrato la strada della sottomissione del Parlamento ad una legge elettorale che puntava ad un presidenzialismo plebiscitario. Quando questo problema si è riproposto, Napolitano ha seguito le regole costituzionali garantite da Scalfaro.
Scalfaro ha agito con forza nell’ambito della Costituzione e valorizzando i poteri che erano previsti per il Presidente della Repubblica e con non erano stati usati con egual forza durante il regime partitocratico.
Quella che nasce con Scalfaro è una Repubblica più presidenziale, con un patto forte fra Presidente e Parlamento. Così facendo ha salvato la nostra Repubblica e la nostra Costituzione. Ha lasciato però aperto un problema che bisognerà pur risolvere: mentre i Presidenti Scalfaro, Ciampi e Napolitano difendevano la centralità del Parlamento, il Parlamento veniva snaturato,offeso ed umiliato da una legge elettorale sciagurata.
L’edificio è ancora pericolante, se a lato di un Presidente della Repubblica che difende la centralità del Parlamento non si dia vita, con una nuova legge elettorale, ad un Parlamento responsabile e cosciente di sé, vero rappresentante della sovranità popolare.
redazione@approdonews.it